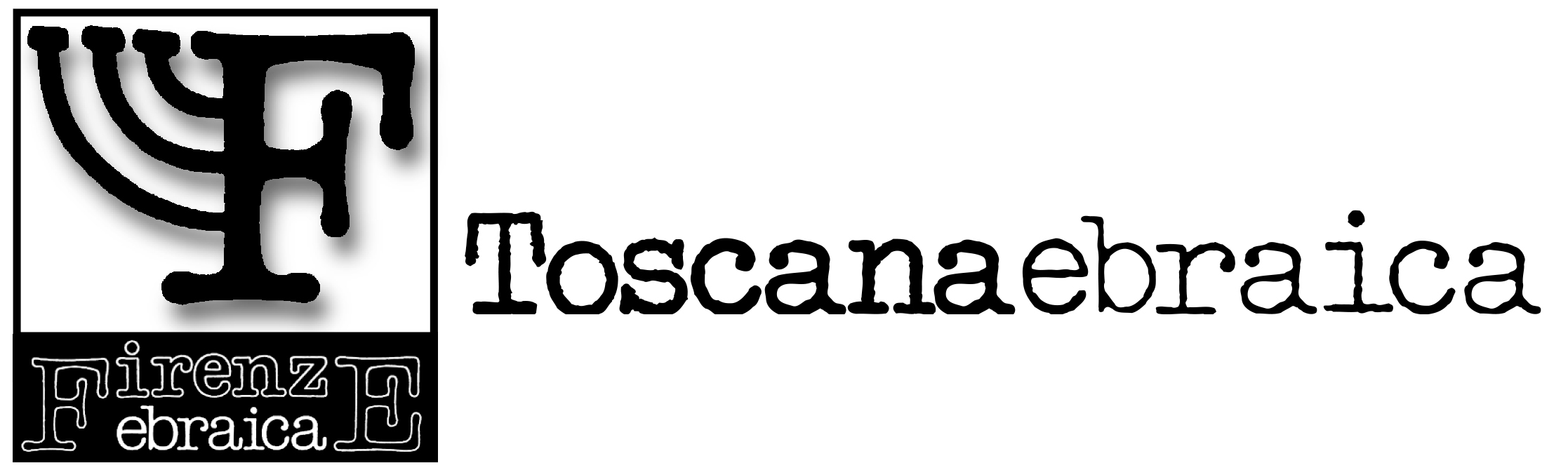Amuleto sefardita, XVIII-XIX secolo. Archivio storico della Comunità ebraica di Pisa (Su gentile concessione della Comunità ebraica di Pisa).
La presenza ebraica a Pisa, attestata fin dal XII secolo, crebbe notevolmente grazie ai Privilegi emessi dal granduca Ferdinando I nel 1591 e nel 1593. Queste lettere patenti erano indirizzate a «mercanti di qualsivoglia nazione», ma essenzialmente a ebrei levantini provenienti dall’Impero Ottomano, nonché a marrani spagnoli e portoghesi che erano rimasti nella Penisola iberica come anussim o cristãos novos. Come per Livorno, il più piccolo nucleo di ebrei italiani della comunità di Pisa venne sostituito via via dalla produttiva e vitale comunità di lingua portoghese e spagnola che letteralmente “ispanizzò” la precedente popolazione ebraica fondando in Toscana una nuova Sefarad. Ne uscì una comunità eterogenea legata al mondo sefardita mediterraneo, con tradizioni liturgiche e pratiche religiose simili ad altre comunità diasporiche in Italia (Venezia, Genova, Ancona) nel Nord Africa (Libia, Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto) in Eretz Israel e nelle terre ottomane. La massima espansione demografica della comunità ebraica pisana si ebbe alla fine dell’Ottocento, quando in città vivevano circa 600 ebrei. Con la promulgazione delle Leggi razziali molti ebrei pisani, fino ad allora occupati soprattutto presso l’Università di Pisa e nelle istituzioni pubbliche, lasciarono la comunità pisana che si ripopolò lentamente solo dal dopoguerra. Oggi il Qahal qadosh di Pisa conta circa 150 membri.
La testimonianza della lunga e ininterrotta presenza ebraica nel territorio pisano si concretizza, oltre che nel suo prestigioso cimitero, nel ricchissimo archivio, perlopiù inesplorato, che contiene materiale documentario dall’inizio del XVII secolo alla metà degli anni Sessanta del Novecento. Registri delle nascite, dei matrimoni, dei divorzi, delle ballottazioni e dei decessi, ketubbot antiche e moderne, libri contabili delle pie confraternite, registri delle sinagoghe e delle sepolture, faldoni di corrispondenze tra i membri più illustri della comunità, sono migliaia le carte contenenti importanti informazioni per lo studio della storia e del patrimonio culturale ebraico toscano. Un primo studio sistematico di alcuni documenti conservati in archivio è terminato proprio lo scorso anno e ha visto coinvolti esperti e studiosi dell’Università di Pisa e del dipartimento di Informatica e Telematica del CNR. Il progetto ASCEPI (Archivio storico della Comunità ebraica di Pisa) volto alla digitalizzazione e informatizzazione del registro dei nati, morti e ballottati di fine Settecento e metà Ottocento, rappresenta il primo passo per rendere fruibili online importanti fonti storiche. Proprio durante lo spoglio dei faldoni, tra le centinaia di carte, ho trovato, all’interno di un armadio e piegato in due, un amuleto manoscritto in ebraico destinato a offrire al suo possessore una protezione divina contro tutti i possibili mali e pericoli. Il manufatto in questione è l’unico del suo genere conservato nell’archivio comunitario di Pisa ed è per questo motivo, e per le interessanti informazioni che può darci sulla storia e sulla cultura della compagine ebraica della città, che ho deciso di darne qui una breve descrizione.
Gli amuleti ebraici, in ebraico קמע (qamea‘) sono spesso composti da frasi prese in prestito dal vasto corpus della letteratura magica e cabbalistica, da citazioni bibliche, e da una serie di nomi sacri, spesso criptici e indecifrabili che, insieme a incantesimi e formule note, hanno il potere di allontanare le forze negative e gli spiriti maligni. Le superfici su cui sono scritte le formule possono essere molteplici (carta, pergamena, oro, argento, osso) come anche le decorazioni che raffigurano spesso sofisticati motivi vegetali o geometrie psichedeliche. Gli amuleti svolgono diverse funzioni: possono facilitare il parto e le unioni matrimoniali, accelerare la guarigione dalle malattie, superare conflitti e guerre o migliorare la salute e la vita di una famiglia o di un’intera comunità. Migliaia di amuleti ebraici sono tutt’oggi conservati in musei, archivi e collezioni private. L’amuleto pisano presenta una scrittura quadrata sefardita senza vocalizzazione scritta sul lato carne di una spessa pergamena di 25 cm x 21 cm, ed è esteticamente molto fine e ben conservato. Da un confronto con un amuleto simile pubblicato da W. L. Nash nel 1906 si deduce che il manufatto pisano potrebbe essere stato prodotto tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo da un rabbino sefardita del Levante. L’amuleto riporta una micrografia sofisticata e complessa: le citazioni bibliche, le benedizioni e le formule magiche formano figure concentriche che racchiudono, come una sorta di protezione, l’iscrizione Shadday (Onnipotente) posta al centro del foglio. Diversamente da altri oggetti simili, il nostro amuleto non riporta il nome della persona per la quale è stato realizzato e pare essere fatto per «chiunque porti questo amuleto su di sé, o per la casa»; solo in un punto il testo sembra alludere a una donna (פלוני זאת). L’amuleto riporta molti versetti della Bibbia: Genesi, Deuteronomio, Numeri e, soprattutto, il libro dei Salmi, frequentemente utilizzati per scopi magici e apotropaici. Alcuni versetti sono citati secondo il principio del notariqon scrivendo solo le lettere iniziali di ciascuna parola del versetto. Proprio lungo il margine del foglio corrono alcune citazioni tratte da Genesi (27,28-29; 28,3-4; 49,25-26) e da Deuteronomio (7,13-15; 28,3-6) in grafia piena, che creano una doppia cornice intorno alla sezione circolare del manufatto. Le citazioni bibliche della Genesi raccontano delle benedizioni del patriarca Isacco e del figlio Giacobbe e del loro legame diretto con la discendenza di Abramo e la terra di Israele.
I versetti del Deuteronomio – la benedizione di Dio sui frutti del grembo e del suolo e sull’accrescimento delle greggi – sono formule potenti per favorire la fertilità e l’abbondanza. I nomi dei quattro arcangeli Rafa’el, Gavri’el, Mikha’el e Uri’el, insieme ai nomi criptici del repertorio magico e di nomi divini basati su variazioni del Tetragramma, girano intorno alla cornice circolare che riporta la benedizione di Giacobbe del figlio Yosef: le parole Ben porat Yosef ben porat ‘alé ‘ayin (Genesi 49,22) sottolineano la fertilità del seme di Yosef e il suo ruolo protettivo contro il malocchio. Infatti, secondo il trattato Berakhot 20a, le parole ‘alé ‘ayin (presso una fonte) dovrebbero essere lette ‘olé ‘ayin (al di sopra dell’occhio). Ciò è confermato dai versetti citati subito dopo tratti dalla benedizione sacerdotale di Numeri 6,24-26 considerata efficace proprio contro i demoni e il malocchio. Questa benedizione, un topos negli amuleti, è scritta prima per intero ed è poi seguita dal notariqon di Numeri 6,27 e ancora di Numeri 6,24-26. All’interno del cerchio troviamo i nomi delle matriarche e di altre donne bibliche – Sarà, Rivqà, Rachel e Le’à; Miryam e Avichi’el (si noti la grafia inusuale) – e dei più noti protagonisti maschili della Bibbia – Moshé, Aharon, David, Shelomò, Shemu’el e Mikhà – inseriti rispettivamente fuori e dentro le sei punte della stella. Ogni nome è associato a una lettera dell’alfabeto la cui combinazione potrebbe rappresentare un versetto biblico o lettere magiche con un’influenza benefica e protettiva. Il testo che forma il primo dei due triangoli equilateri del Maghen David contiene un gruppo di lettere identificabili con l’acronimo del Salmo 67,1-7 e dalle iniziali delle parole che compongono il “Nome di quarantadue lettere” tratto dalla preghiera mistica di Nechunyà ben ha-Qanà, Annà bekoach (Deh, con la forza). Il testo del secondo triangolo contiene una formula contro la paura, le malattie e le avversità generate da tre gruppi di demoni maschili e femminili, shedin, ruchin e lilin, creati da Dio e che si dice uccidano i bambini o attacchino uomini e donne nel sonno. Ciascuna punta del Maghen David si interseca poi con un triangolo dando forma a sei esagrammi più piccoli il cui testo sovrascritto va letto consecutivamente a partire dal triangolo in alto a destra e poi verso sinistra. Qui leggiamo il secondo emistichio di Genesi 28,4 e lo yichud (unificazione) dei due Nomi divini che formano il cosiddetto “Nome di otto lettere” יא-הד-ונ-הי. Il testo del Salmo 128,1-6 occupa poi il resto della micrografia augurando al possessore del manufatto una vita familiare longeva e felice, ma anche protezione dall’aborto spontaneo, dal parto prematuro o dall’infertilità (forse il cliente è effettivamente una donna, secondo quanto già anticipato all’inizio). Segue poi il notariqon di Deuteronomio 28,10.
Al centro dell’amuleto, all’interno di una decorazione floreale, si trova il termine Shadday in caratteri quadrati. È diffusa la credenza che non solo le invocazioni scritte, e recitate ad alta voce, siano un dispositivo di protezione. Il nome divino riportato in lettere monumentali e collocato al centro del foglio concentra su di sé tutto il potere apotropaico dell’amuleto.
Sarebbe un compito difficilissimo scovare le origini precise del portafortuna in questione; forse però vale la pena riflettere meglio sul contesto storico-geografico della comunità ebraica toscana e sui rapporti instaurati tra quest’ultima e quella ben più sviluppata di Livorno, con alcuni rabbini itineranti che giungevano in Italia grazie a intricate reti di ospitalità, non solo per raccogliere offerte per le comunità in Terrasanta, ma anche per diffondere e pubblicare le loro composizioni liturgiche. Fino ad oggi le notizie sulla presenza di inviati dalla Palestina ottomana nel corso del Sei-Settecento a Pisa erano scarsissime, e questa assenza è motivata dal ruolo estremamente centrale di Livorno che si distinse anche in questo campo, accanto a Venezia e Amsterdam, come centro di raccolta delle offerte. L’archivio pisano conserva però alcune decine di lettere in lingua ebraica che testimoniano il passaggio di rabbini dalla Palestina a Pisa. Gli shelichim provenienti da Eretz Israel contribuirono in maniera determinante alla diffusione delle dottrine cabbalistiche sviluppate dagli esuli sefarditi nella città di Safed nel tardo ’500. Erano rabbini preparatissimi, spesso figli, nipoti e padri di rabbini, maestri dello Zohar, e vantavano discendenze incredibili con cabbalisti insigni conosciutissimi. Per quel che concerne i più eminenti inviati in Italia, non si può non ricordare il rabbino Chaim Yosef David Azulai, vissuto tra il 1724 e il 1806 e stabilitosi a Livorno. Mistico per eccellenza, partì da Hebron alla volta delle capitali più importanti d’Europa facendo tappa anche sulle coste dell’Africa settentrionale. Nel 1778 si stabilì definitivamente a Livorno, dopo essersi risposato il 28 ottobre con una Rachele a Pisa, e da lì accentrò tutte le sue attività: studio, pubblicazione dei suoi libri di mistica e raccolta fondi per le comunità di Terrasanta. Le lettere conservate presso l’Archivio della Comunità ebraica di Pisa ci raccontano storie molto simili. Risalgono tutte al Settecento e, come detto, si rivelano una fonte storica di estrema importanza perché restituiscono alla comunità ebraica pisana un ruolo centrale all’interno della fitta rete filantropica che legava da secoli le comunità diasporiche alle comunità di Eretz Israel. Chiunque abbia seguito la vita e le tappe dei messi rabbinici sa che questi personaggi, per arrotondare il loro salario, consapevoli della loro influenza sui fedeli, erano soliti redigere, su richiesta, amuleti contro il malocchio, talismani e chincaglierie con formule salvifiche in lingua ebraica. Uno di questi è ancora Azulay, che non solo influenzò il pensiero magico ebraico, ma impose nuove istruzioni per la scrittura degli amuleti nel XVIII secolo. Grazie alla sua grande erudizione e ai suoi viaggi in Europa, l’uso dei qemiʻot tornò in auge dopo un periodo di declino. È difficile supporre che questi fatti non abbiano avuto una qualche influenza sulle credenze e sulle pratiche dell’ebraismo pisano; al contrario, potrebbero gettare una luce nuova sull’origine dell’amuleto qui esaminato.