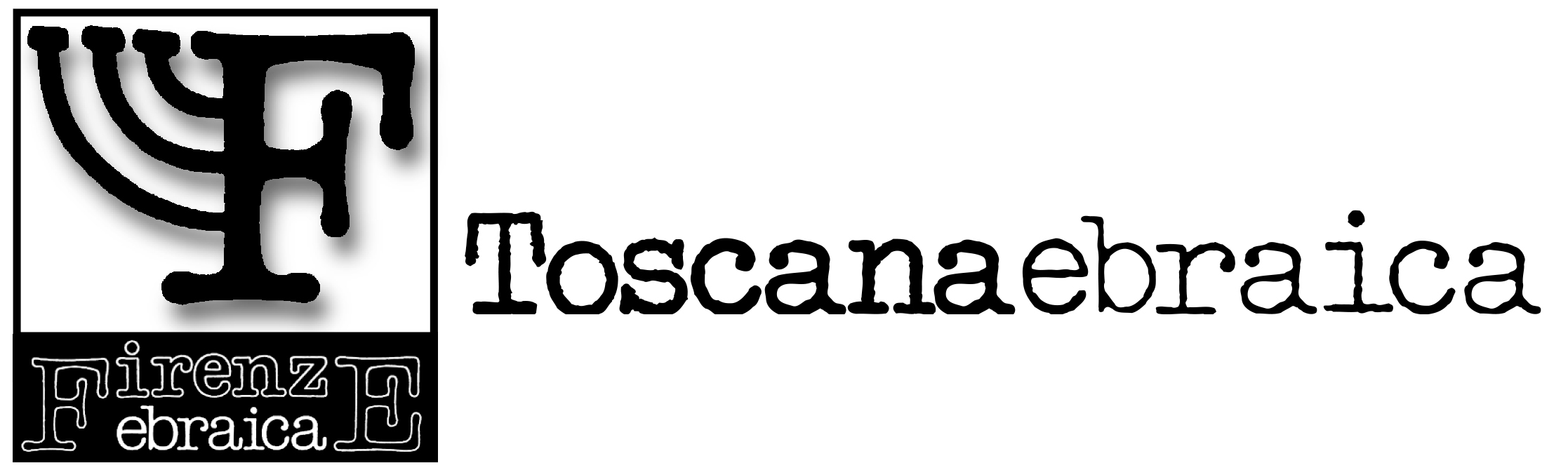Chanukkyà. Ottone sbalzato parzialmente argentato. Scuola Bezalel, Zeev Raban. Gerusalemme, 1920 ca.
Breve racconto sui riferimenti rituali simbolici della menorà di Chanukkà: diversità e somiglianze con la menorà del Tempio
La menorà di Chanukkà, che da fine Ottocento, su suggerimento di Hemda Ben-Yehuda, si conosce come chanukkyà, è un candelabro composto da otto lumi che rappresentano ciascuno gli otto giorni di durata della ricorrenza, più uno che funge da “servitore”, chiamato shammash, e che viene adoperato per l’accensione degli altri. Secondo Bet (la scuola di) Shammay, i lumi si accendono tutti il primo giorno della festività, togliendone uno per ognuno dei giorni successivi, mentre per Bet Hillel – che viene seguito oggi dalla maggioranza – si procede in ordine crescente, cioè accendendo un singolo lume alla vigilia della festività e poi aggiungendone uno ogni giorno successivo.
La ricorrenza ricorda la vittoria di Yehudà il Maccabeo su Antioco IV Epifane, a seguito della quale fu possibile riconsacrare il Tempio dopo la coatta profanazione dei Seleucidi. La percezione della riguadagnata libertà da un oppressore si è presentata come un intreccio di sentimenti religiosi e laici, consolidati dopo la distruzione del Tempio per mano di Tito, evento che segna l’inizio della diaspora, la “galut” del popolo ebraico. La vittoria e la centralità del Tempio dei Maccabei viene quindi sublimata con l’accensione ritualizzata dei lumi.
Non sfugge l’associazione tra la menorà del Tempio e la chanukkyà, nonostante la differenza del numero dei lumi, la prima infatti ne ha sette, a rappresentare i giorni della settimana. La chanukkyà evoca il mito e il “miracolo dell’olio”: si narra che, al momento della riconsacrazione maccabea, nel Tempio vi era una quantità irrisoria di olio “puro” ma, per un “prodigioso caso”, bastò invece per l’accensione della menorà d’oro, per otto giorni, il tempo necessario per acquisire poi le quantità occorrenti.
I riferimenti immaginifici e le tipologie della “menorà di Chanukkà” si sono consolidati, dal Medioevo, come metafora di un’architettura d’eccellenza –Il Tempio di Gerusalemme – ma, in sostituzione del suo aspetto reale che intanto si era perso, spesso l’edificio o il monumento più in vista nei luoghi nei quali gli ebrei risiedevano è diventato quello utilizzato come modello, fenomeno questo che si è ampiamente diffuso (Figg. 1a-b e 2a-b).


Collateralmente all’immaginario della “casa” si trova ricorrente quello dell’albero, l’olivo, una pianta alla quale il mito di Chanukkà è solo uno dei tanti, e non solo ebraici, che le sono attribuiti. Già la menorà del Tempio (a differenza di quella scolpita sull’arco di Tito, simbolo della capitolazione e della perdita della autodeterminazione) potrebbe essere considerata una stilizzazione di un albero, un’ipotesi che diventa maggiormente plausibile se si considera che la menorà è composta, secondo la descrizione biblica, da kaftor (bocciolo) e perach (fiore) (Fig. 3).

Dalla spremitura del frutto dell’olivo si ricava l’olio, fortemente associato alle ritualità, alla vita, al sacro, che si trovano uniti nelle metafore della luce, e per accrescere l’effetto luminoso spesso le chanukkyot sono realizzate di metallo riflettente, specchiante.
La cacciata dell’oscurità rimane una delle metafore di Chanukkà, festività che cade nel periodo dell’anno in cui le ore di luce sono minori, ma da lì in poi le giornate iniziano ad allungarsi. L’usanza è quella di divulgare attraverso la luce, anche ai goyim, l’avvenuto miracolo, esponendo le chanukkyot accese sui davanzali delle finestre delle case o, come avviene a Gerusalemme, appendendole all’esterno sulle loro facciate (Fig. 4).

Il movimento sionista, e in seguito lo Stato d’Israele, hanno adottato Chanukkà per i valori libertari e laici che coincidevano con i propri presupposti fondanti d’indipendenza nazionale. I Lubavitch, invece, hanno colto la potenzialità di Chanukkà trasformandola in occasione inebriante per la propria “riconoscibilità identitaria”. L’immagine della menorà è stata stilizzata, la nuova forma è riproposta come un’icona, e la cerimonia dell’accensione del candelabro è fatta uscire dalle case private ed elevata ad azione eclatante, pubblica, in una piazza cittadina centrale e in presenza delle autorità, intorno ad una menorà gigante “monumentale” (Fig. 5).

La prossimità della festività ebraica al Natale e “l’americanizzazione” avvenuta con il movimento Chabad, a seguito della Shoà, non possono che porre qualche interrogativo su queste associazioni!
Le chanukkyot oggi si rifanno ancora prevalentemente ai modelli del passato, ma l’Accademia Bezalel di Belle Arti di Gerusalemme, all’inizio del Novecento, spinta dai sentimenti risorgimentali del sionismo, ha scelto di “attualizzare” la retorica delle simbologie della ricorrenza: ad esempio con il Muro del Pianto, il Leone o la stessa menorà (Fig. 6), esperienza però che è rimasta rinchiusa in se stessa, “relegata” a souvenir nostalgici.

Il “design industriale” di “oggetti per la fede” con il Modernismo (per esempio la scuola del Bauhaus) è in genere percepito dal largo pubblico sterile, privo di emozioni.
Più recentemente ci sono artisti che utilizzano linguaggi espressivi e materiali contemporanei, ispirandosi a questi temi o ad altri simili; ma anche se alcuni hanno raggiunto dei risultati notevoli (un esempio è la collezione di chanukkyot curata da Elio Carmi a Casale Monferrato [Fig. 7]), per la loro intrinseca configurazione non possono essere considerati di funzione rituale, in quanto si presentano ormai come oggetti da collezione.