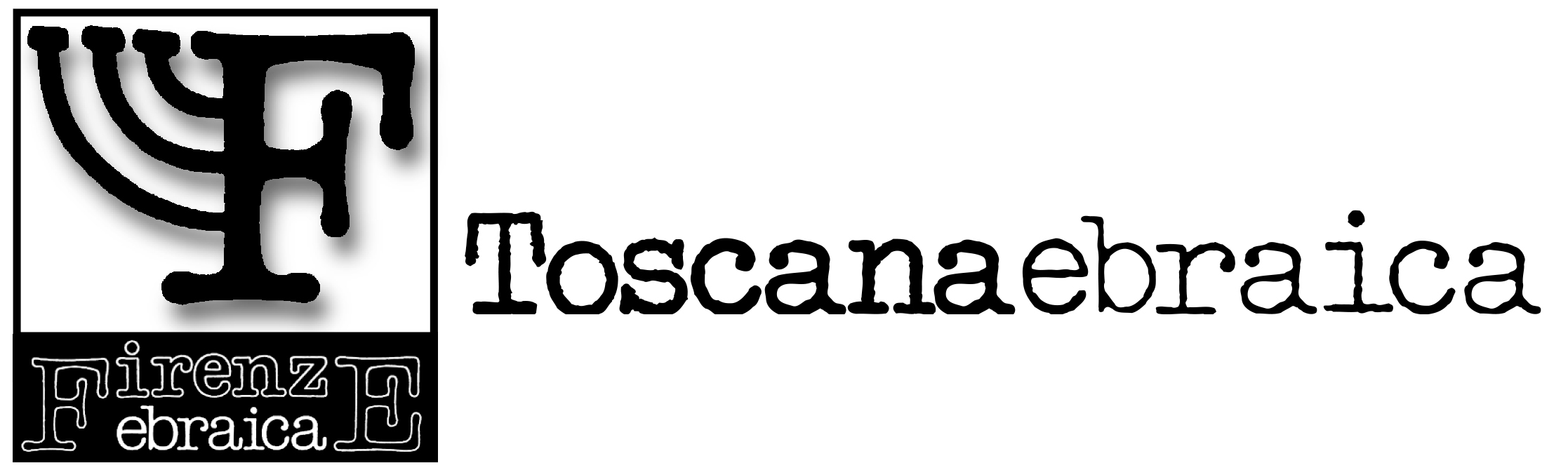Marc Chagall, Moses spreads the darkness over Egypt (1931), acquaforte su carta (Credit: Wikiart.org).
Stranamente sono rare le opere d’arte dedicate alle piaghe d’Egitto, nonostante i valori spirituali che trasmettono e la teatralità delle relative morti, malattie, disastri atmosferici, invasioni di animali vari. Il poco che è stato prodotto, però, vale la pena di essere osservato con cura, a partire da due importanti tele di Joseph Mallord William Turner (1775-1851), uno dei maggiori se non il maggiore pittore del Romanticismo del primo Ottocento. Dipinse La quinta piaga d’Egitto (Fig. 1) da giovane, quando aveva venticinque anni, ma con talento da vendere e idee innovative da proporre al mondo dell’arte dei suoi giorni. Allora andava per la maggiore la pittura impersonale legata agli ideali universali della Rivoluzione Francese (come in David) o la riproduzione su tela quasi fotografica dei paesaggi (come in Carlisle). Turner, invece, sottolineava che quello che vediamo e come lo vediamo dipende in gran parte dal nostro stato d’animo: quando siamo felici tutto ci sembra bello, e, al contrario, tutto si fa scuro quando l’umore non è buono. I suoi paesaggi non sono altro che espressioni di un sentimento. In La quinta piaga d’Egitto l’accento è su quanto siano insignificanti la natura e l’uomo con le sue creazioni rispetto alla grandezza di Dio. Mosè è appena visibile in basso e delle grandi piramidi di Giza se ne vede solo una, mentre il cielo è un turbine, con mulinelli che paiono poter spazzare via ogni cosa, con una massa bianca che cade da un lato e una corrente rosso-fuoco che sale dall’altro. Non mancano quindi i riferimenti all’esegesi della piaga della grandine – il titolo “la quinta piaga” è un errore che la dice lunga su quanto poco si sapesse di questa pagina di Torà – ma il senso di riverenza che si percepisce conta eccome. Verrebbe voglia di prendere un aereo per Indianapolis e lì vedere dal vero questo Turner.
Più facile da ammirarsi è la sua La decima piaga d’Egitto, esposta alla Tate Gallery di Londra e dipinta un paio di anni dopo rispetto alla “quinta”. Anche qui, come spesso accade in Turner, è il cielo a colpire particolarmente, con forme e colori che di reale hanno poco. A sinistra una nuvola nera che oscura la natura e piega con forza un albero carico di frutti che simboleggia la ricchezza terrena; a destra spicca l’azzurro sereno che sta per essere spazzato via, aumentando il senso di terrore per quel che sta per accadere. Colpisce poi come Turner attualizzi la decima piaga, la riporti alla realtà dei suoi tempi. La città rappresentata non ha niente a che fare con l’Egitto – sembra invece tipicamente europea con i suoi castelli, torri e mura, casomai una di quelle duramente colpita dalle guerre napoleoniche allora in pieno svolgimento. In basso, dove la morte è già passata, si distinguono sia un gruppo di donne con vestiti d’altri tempi, sia un lavoratore – pare più un operaio che un contadino – che piange la morte del figlio. Come a dire che anche nell’Inghilterra di inizio Ottocento, la piaga della morte colpiva i primogeniti sia in guerra sia nelle fabbriche con il duro lavoro. Il messaggio era fin troppo sbilanciato politicamente, tanto che Turner volle sempre tenere quel quadro nel suo studio e solo nel suo testamento lo lasciò allo Stato inglese che lo sistemò alla Tate. Da notare anche che nei disegni in cui l’artista prese spunto dal quadro, le figure sono tutte di tempi antichi, e i riferimenti contemporanei più dirompenti sono stati abbandonati.


L’influenza di Turner è ben tangibile in Settima piaga d’Egitto di John Martin (1789–1854) (Fig. 2), un altro inglese; nel 1821 venne considerato “Il pittore contemporaneo più noto”, mentre oggi non lo è più di tanto. La sua tela dedicata alla settima piaga, però, è ben riuscita: la parte che più impressiona è anche qui il cielo, in cui si mischia la grandine che cade, lo scuro della tempesta e il rosso del fuoco. Tutto questo sta per abbattersi su un gruppo di imponenti edifici egizi riprodotti in tutta la loro magnificenza, incluse le piramidi e una serie di templi, che però solo apparentemente sono indistruttibili; in effetti, non offrono alcun rifugio al popolo che si accalca sulla sponda a guardare con orrore quanto accade. Come in Turner, colpisce il contrasto fra i vari colori utilizzati, e fra le piccole dimensioni e il posizionamento defilato delle figure, Mosè incluso, rispetto al cataclisma prodotto dalla natura. Peccato che la tela sia appesa a Boston.
Altro artista che si è ispirato alle piaghe è il francese James Tissot (1836-1902), oggi poco noto al grande pubblico, anche se di buon successo mentre era in vita. Si mosse sempre controcorrente: mentre tutto il mondo andava a Parigi, lui si spostò a Londra; diventò impressionista quando nessuno lo era e smise di esserlo quando tutti lo erano diventati. Nella piena maturità, recuperò i valori religiosi dell’infanzia come aveva predicato Napoleone III, ma lo fece intorno agli anni ’80, una decina di anni dopo l’abdicazione di quel nipote del grande generale corso. Non solo, anche se compì ben tre lunghi viaggi in Medio Oriente fra il 1883 e il 1896, quando tornò a casa non si mise a dipingere scene tipiche del mondo arabo con figure in costume, come andava allora di moda (basta pensare anche alla nostra Sinagoga) e come è molto apprezzato dai collezionisti anche oggi. Utilizzò invece le impressioni ricavate da quel suo vagabondare per rendere più realistiche le tele incentrate su Vangeli e Torà che intanto aveva iniziato a dipingere. Ed è proprio in quel periodo che dedicò diverse tele alle piaghe d’Egitto, la maggior parte delle quali si trova oggi al Jewish Museum di New York. Non si tratta di arte particolarmente elevata e soprattutto coinvolgente: si tratta piuttosto di una riproduzione abbastanza fedele delle scene descritte in Shemot, con costumi e ambientazione corretti, ma poco di più. Spesso i personaggi coinvolti alzano le mani verso l’alto con gesti molto evidenti – come le donne egizie nella prima piaga del Nilo che si trasforma in sangue o Mosé (e Aron) nella piaga della grandine – ma non riescono a trasmettere molto all’osservatore. I colori pastello e i contorni marcati delle figure non aiutano.

Stranamente anche Chagall si è poco interessato alle piaghe, anzi pochissimo, eccezion fatta per Darkness over Egypt. Si tratta di un’acquaforte, cioè di una lastra di metallo incisa e utilizzata come stampo per ricavare un qualsiasi numero di stampe – in questo caso 100. In genere le stampe così ricavate sono in bianco e nero, ma qui Chagall ha dipinto la figura di Mosè in giallo a sottolineare la sua ebraicità, una scelta carica di significato nel 1931, quando il pittore realizzò quest’opera. Significativo e profetico è pure come intorno alla figura di Mosé si diffondano le tenebre, come nella nona piaga d’Egitto, ma anche come nell’Europa di quegli anni.
Di tono del tutto diverso e con riferimenti solo indiretti agli eventi di Pesach, è un quadro di Pieter Mulier il Giovane (1637-1701), un olandese che trascorse tutta la vita artistica in Italia, tanto da guadagnarsi il nomignolo in italiano di “Cavalier Tempesta”, in riferimento ai soggetti che più amava. Nel suo Paesaggio con Mosè e Aron che pregano per fermare la piaga della grandine sull’Egitto (Fig. 3), però, c’è poca traccia dell’evento atmosferico terrificante della piaga. In effetti Mosè e Aron si trovano in secondo piano, appena visibili seppur illuminati con un fascio di luce, e la città si scorge appena sullo sfondo, ai piedi di un insieme di colline di sapore europeo più che di dune di sabbia o di qualcosa di imparentato con il panorama egiziano. In primo piano, invece, risaltano alcuni pastori placidamente intenti al loro lavoro e i loro animali pasciuti. Evidentemente Cavalier Tempesta voleva far riferimento alla vita nella regione di Goshen abitata dagli Ebrei in Egitto, rimasta immune dai disastri delle piaghe. Un quadro rilassante, quindi, dai colori caldi, creato secondo la moda del tempo in cui andavano per la maggiore paesaggi bucolici idealizzati. In Italia si viveva allora un periodo di pace ed era meglio lasciare perdere la tragedia delle piaghe – che risuona quindi soprattutto in Turner e in Chagall.